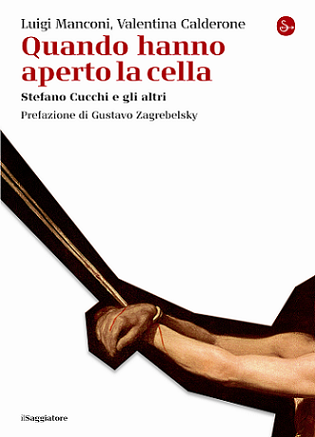Fabio Sommovigo avvocato spezzino, penalista, é intervenuto – sabato 27 luglio al castello di San Terenzo – all’incontro di presentazione del libro “Quando hanno aperto la cella. Stefano Cucchi e gli altri”, organizzato dall’associazione “PecoraNera”. Il tema dei diritti dell’individuo quando si trova davanti allo Stato Leviatano è di grande interesse e di grande attualità per il paese, anche se pare che l’“agenda” politica lo ritenga secondario. Non sono dello stesso avviso le associazioni di cittadini che con fatica e per amore di libertà organizzano incontri e dibattiti per invitarci alla riflessione.
Ciao Fabio, lo scorso anno al Piasseo 2012 hai parlato con noi dei fatti di Genova e della sistematica violazione del diritto e dei diritti di cui quelle giornate sono state prova pratica. Quest’anno in quasi coincidenza con il Piasseo 2013 che apre questa sera torni nel lericino, a San Terenzo, a parlare di carcere e diritti delle persone. C’è un filo rosso che lega i due temi e il tuo impegno?
Assolutamente sì. Direi, anzi, che si tratta sostanzialmente dello stesso tema: l’essere umano – il suo corpo – affidato alle polizie, agli organi della giustizia penale e, talvolta, alle strutture “sanitarie”, che esercitano il potere repressivo, “il monopolio della violenza” dello Stato. Purtroppo la nostra storia, anche – o forse dovremmo dire soprattutto – recente, dimostra come non sia eccezionale il ricorso a forme di mortificazione della dignità umana quando le persone si trovano in condizione detentiva, fino agli estremi dell’uso esplicito della violenza, a volte con conseguenze letali.
In questa prospettiva il testo di Manconi e Calderone rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per la ricostruzione della storia e dei modi della repressione nel nostro paese, della sofferenza inflitta alle persone che a vario titolo si sono venute a trovare “nelle mani” dello Stato; una storia raccontata attraverso le vite e i corpi, le esperienze reali, vivide e perciò scandalose, degli esseri umani protagonisti, loro malgrado, di vicende note, o del tutto sconosciute alla cronaca.
Fra quanto accaduto a margine del vertice del G8 di Genova nel 2001 e le condizioni “ordinarie” della detenzione nei nostri istituti di pena il collegamento è costante e circolare ed è rappresentato dalla persistente incapacità dell’Italia di darsi istituzioni repressive seriamente rispettose dei diritti fondamentali e di dotarsi strumenti di controllo efficienti e severi.
Il nostro sistema delle pene con il modo della loro esecuzione sono lo specchio del paese? Mi spiego meglio è davvero possibile riformare il sistema delle pene in Italia o rimane una battaglia di pochi incomprensibile per il paese, sempre impegnato a risolvere altre urgenze?
Il mondo dell’esecuzione penale, la dimensione del carcere in particolare, è stata tradizionalmente – e rimane oggi – l’oggetto di una costante opera di rimozione, di distinzione fra “noi” – gli onesti cittadini – e “loro” – i criminali – Ed è una distinzione che i primi pensano di poter immaginare come netta e invalicabile.
Questo atteggiamento mentale ha legittimato e legittima forme di imbarbarimento dell’esecuzione penale, forme di detenzione senza colpa, senza rimprovero – per esempio i C.I.E., in cui i migranti possono essere reclusi senza aver commesso alcun reato -, sostanzialmente finalizzate alla rimozione per l’appunto, all’espulsione almeno temporanea dalla società dei soggetti pericolosi, indesiderati, o anche solo “difficilmente collocabili”.
Ma quel che è peggio, una simile disattenzione, talvolta maliziosa, della società civile e politica per le modalità concrete con cui si realizzano le diverse forme di detenzione ha portato l’Italia a commettere, ormai quotidianamente ed istituzionalmente, violazioni dell”l’habeas corpus”, che fu – dal Medioevo – il primo baluardo della protezione dell’individuo dalla violenza sovrana,
Il corpo dei detenuti, inteso quale integrità fisica della persona, nonché quale nucleo minimo e insormontabile della sua dignità, si trova ad essere oggi, infatti, l’oggetto delle condanne che il nostro paese riceve con sempre maggior frequenza da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo che censura, per l’appunto, i modi con i quali l’Italia infligge in concreto le pene che i giudici hanno irrogato o, addirittura, le modalità di esecuzione del carcere preventivo.
La Costituzione della Repubblica Italiana, all’art. 2, impone il rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo.
Non so se le riforme penali e carcerarie – quelle che mirano al rispetto dei diritti fondamentali e non, invece, all’introduzione di nuovi strumenti repressivi – siano destinate necessariamente a costituire battaglie di minoranza, so per certo, però, che chiunque – privato cittadino o, a maggior ragione, pubblico funzionario – non si mobiliti fattivamente e con urgenza per rimuovere (anche con misure eccezionali) lo scandalo insopportabile della costante violazione dei diritti umani fondamentali da parte degli organi dello Stato nei confronti degli uomini e delle donne in stato di privazione di libertà, concorre a mortificare ogni giorno la Costituzione, con tutto quel che ciò comporta, anche nella prospettiva della tenuta tout court dello “stato di diritto”.
In altre parole, se si vuole sperare di mantenere accettabile il livello di civiltà di questo paese, non credo vi sia urgenza più pressante di questa.
Una domanda più personale. Perché un avvocato penalista impegna il suo tempo privato nella divulgazione delle ‘questioni di libertà’ ?
Perché il senso profondo della mia professione, la funzione prima dell’avvocato penalista, è di rappresentare la parte debole, perché tale è l’imputato nel processo penale ancora oggi, nonostante il nuovo codice repubblicano e i numerosi interventi della Corte Costituzionale.
L’imputato è “il debole”, voglio precisarlo, indipendentemente dalla sua storia personale prima di essere imputato e indipendentemente dalla gravità dei crimini che gli sono attribuiti dalla procura.
E non di rado l’avvocato è unico schermo di protezione giuridica, e spesso umana dell’individuo di fronte al possente apparato repressivo dello Stato. Chi non è stato – ancora – investito dalla macchina della giustizia penale difficilmente immagina quale ne sia, per molte e diverse ragioni, la portata a volte devastante sulla vita degli individui.
Vivendo professionalmente all’interno di questo sistema ci si rende conto di quanto essenziali siano, anche nella prospettiva del reale accertamento della verità, le garanzie dei diritti fondamentali, di quanto intangibili debbano essere gli spazi di libertà e di dignità riservati agli individui e, soprattutto, di quanto precarie siano – continuamente in bilico, a rischio di revoca, facilmente comprimibili – le tutele della persona, anche quelle che sembravano acquisite una volta per tutte.
Frequenti ondate di furore repressivo e di risposte panpenalistiche ai più diversi problemi percorrono la penisola
E non di rado, ahimè, anche su ispirazione di forze politiche e/o organizzazioni sociali di “sinistra”, mettendo in dubbio, a più riprese, le garanzie fondamentali e processuali, la loro utilità e facendo spesso vacillare i pilastri del diritto di difesa che sarebbe “inviolabile” per la Costituzione, il cui esercizio nelle cronache e nei commenti giornalistici viene ridotto, non di rado, all’immagine del “cavillo” che pone un intollerabile freno al libero incedere dell’accertamento della verità.
E’ per queste ragioni che credo sia parte costitutiva del ruolo del penalista, che vive da cittadino nella società, quella di testimoniare e richiamare l’attenzione, ogni volta che ciò si rende possibile, sul rispetto dei diritti fondamentali e sul pericolo che rappresenta per i cittadini l’esercizio – senza costanti, rigorosi ed efficaci controlli pubblici e diffusi – del potere repressivo dello Stato attraverso gli organi della giustizia penale.